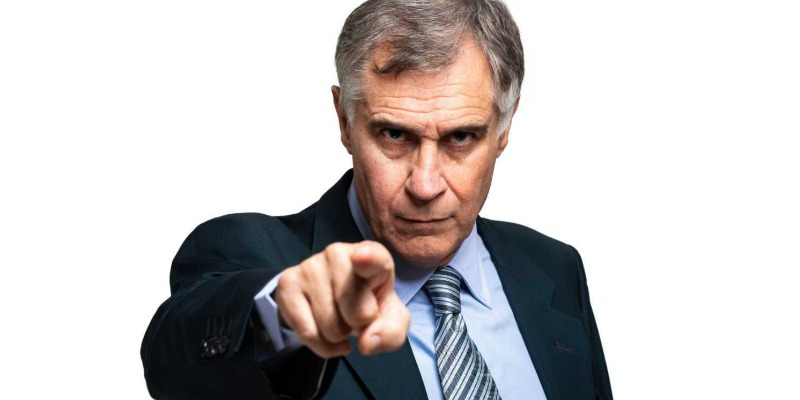
 La Distorta Gestione del Potere in Azienda per Proteggersi
La Distorta Gestione del Potere in Azienda per ProteggersiUn collaudato e pericoloso modo di gestire i collaboratori in modo da non essere coinvolto in critiche o colpedi Marco ArezioAbbiamo parlato, in alcuni precedenti articoli, delle diverse strategie manageriali sulla gestione delle attività dei lavoratori del proprio team, finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi, assegnati ad ogni manager, da parte delle aziende. In particolare si è sviscerata la tematica del “Divide et Impera” che spinge alla massima competizione tra le risorse umane, lasciando che vi siano momenti di attrito e di lotta intestina, per alzare sempre più l’asticella della tensione professionale e facilitando lo scorrimento di un’adrenalina costante. La posizione del manager che gestisce da fuori la lotta, i vantaggi o gli svantaggi di questa pratica, sono elementi da prendere con estrema attenzione per i risvolti che questo approccio può ingenerare. Il “divide et impera” potrebbe portare ad un vantaggio negli obbiettivi aziendali, in particolari condizioni e con un’attenta analisi interna del team da parte del manager, ma non è, ovviamente, la sola teoria passiva che un manager può introdurre. Infatti, può anche emergere nelle aziende un’altra diffusa pratica di gestione dei lavoratori, che è quella di un responsabile di team o di più teams che “usa” i collaboratori per proteggere la propria posizione apicale. Sono managers complessi, dal carattere sfuggente, dal modo di ragionare non sempre lineare, che fanno della manipolazione della forza lavoro un mezzo per consolidare la propria posizione, assorbendo dal lavoro quotidiano i vantaggi di tale gestione, sia che si tratti di successi, quindi le sua vittorie, che di insuccessi della squadra, quindi le sconfitte e l’incapacità dei singoli. Il principio del loro operare è quello di coinvolgere i collaboratori nelle attività quotidiane, trasferirgli il concetto di responsabilità del lavoro e l’entusiasmo degli obbiettivi, con la capacità di far nascere nelle persone quel senso di dedizione alla causa e al sacrificio. Elogia, spinge, rimprovera con garbo, assegna compiti chiedendone la condivisione al gruppo o ai singoli, fa squadra e mantiene alta la competizione, crea una sorta di dipendenza dei collaboratori nei suoi confronti, una forma sottile di gratitudine perpetua verso sé stesso, una sensazione di debito mai estinguibile verso il capo, senza mai, in ogni caso, entrare nelle scelte e nelle decisioni in modo diretto. Finge una neutralità costruttiva, una forma di francescana di aiuto alla crescita dei collaboratori, uno modo di spingerli a migliorarsi professionalmente, attraverso l’assunzione delle proprie responsabilità nei confronti degli obbiettivi e dell’azienda. Crea addirittura una forma astratta di riconoscenza da parte dei collaboratori, che vedono la sua figura come un tutore quasi disinteressato alla sua posizione apicale, che si adopera a far crescere i managers del futuro, che condivide la propria intelligenza per migliorare la capacità deduttiva e decisionale dei collaboratori. Molto spesso, però, succede che il manager non vuole sporcarsi le mani con decisioni spinose, rischiose o scomode, che, tuttavia, il suo ruolo gli chiederebbe di assumersi personalmente, anche a tutela del proprio team. È astuto nel capire che la sua posizione dipende dal buon risultato del lavoro dei suoi collaboratori, di cui si assumerà i meriti nel momento in cui la squadra raggiunge o supera gli obbiettivi aziendali, ma che in caso di errori o insuccesso negli obbiettivi, deve dimostrare di saper intervenire per sanare la situazione in modo che sia palese, a tutti, che l’evento negativo non è di sua responsabilità. Questo suo atteggiamento costruisce una comunicazione chiara verso i suoi superiori, circa i suoi sforzi nel cercare il colpevole o i colpevoli dell’insuccesso, dimostrando che la sua visione della gestione o della problematica sarebbe stata diversa, e che all’interno del team potevano esserci delle “mele marce” da isolare. Un comportamento adatto a galleggiare sui problemi senza venire travolto, avendo agito in modo di attribuire le colpe a chi si è esposto tra suoi collaboratori, questi, ingenuamente pensando che la squadra nel suo complesso, capo compreso, condividesse le scelte fatte. Il collaboratore che fino qui ha lavorato con soddisfazione nel portare il proprio apporto all’azienda, vivendo le piccole luci della ribalta, godendosi le piccole invidie dei colleghi per uno speciale rapporto professionale con il manager da cui dipende, aveva l’autoconvinzione che il gruppo, incluso il suo referente, aveva ragionato e deciso insieme le migliori strade da seguire. Invece si troverà isolato, nella colpevolizzazione di essersi assunto decisioni in maniera autonoma, senza l’avvallo esplicito e chiaramente comunicato del proprio superiore, con quello che probabilmente era la routine, diventa l’eccezione di un comportamento mai autorizzato. Ciò che era chiaro a tutti, a voce, non lo è più per il superiore e di conseguenza probabilmente anche per i suoi colleghi, che per ovvie ragioni potrebbero non prendere le su posizioni difensive o addirittura negare l’evidenza per convenienza. Riaffiorano le vecchie ruggini, le rivalse sopite, le nuove alleanze nel team, l’ambiente si fa caldo e spinoso al punto che sono possibili delle rese dei conti interne. Ogni manager che adotta questa politica difensiva per la propria posizione, in maniera un po' differente in base all’azienda, al mercato e al suo carattere, tenderà a peggiorare la condizione dei collaboratori a cui ha deciso di addossare le colpe di una situazione negativa, perché salvarli vorrebbe dire che, in qualche modo, avvallare ciò che loro hanno fatto e che avrebbe, invece, dovuto fare lui al posto loro.
SCOPRI DI PIU'
 Il Rischio di Emarginazione ed Oblio di Alcune Risorse Umane in Azienda
Il Rischio di Emarginazione ed Oblio di Alcune Risorse Umane in AziendaQuali meccanismi umani e psicologici il manager deve tenere monitorati per aumentare la partecipazione corale del team di lavorodi Marco ArezioC’è un detto, molto conosciuto, che recita: su una barca tutti devono remare nella stessa direzione per arrivare alla meta il più in fretta possibile, dividendo gli sforzi in modo equo. L’azienda è forse la migliore espressione di questo sforzo corale delle risorse umane, che lavorano in modo serrato e all’unisono per raggiungere quegli obbiettivi che dovrebbero essere condivisi dal gruppo. Non tutti hanno la stessa forza e le stesse caratteristiche da destinare al lavoro, ma ognuno rappresenta un tassello della squadra su cui fare affidamento, nell’azione complessa che porta l’azienda verso il raggiungimento dei propri obbiettivi. All’interno di un team, le persone sono l’espressione di sé stesse, del proprio vissuto, del proprio carattere e delle proprie capacità, univoche e particolari, che possono differire da quelle di altri ma non per questo migliori o peggiori. All’interno della squadra, la componente caratteriale di ogni singola persona determina giochi di forza tra i colleghi, spingendo i più intraprendenti ed ambiziosi ad imporsi sugli altri, a volte in modo positivo, quindi attraverso l’esempio, le doti di leadership e di carisma, a volte incidendo negativamente sui colleghi, con il tentativo di minimizzare la collaborazione allo scopo di emergere sugli altri. È facile intuire che una squadra, in cui si creino delle frizioni, delle emarginazioni e delle denigrazioni tra le persone con un fine ben preciso, gli elementi più fragili dal punto di vista caratteriale, i più sensibili, i meno sicuri di sé, chi non riesce a sopportare uno scontro strisciante nel tempo con gli elementi più forti, possano in breve tempo soccombere. Un tipo di leadership all’interno della squadra che usa questi metodi è poco proficua per l’azienda, in quanto mancando uno sforzo corale e coordinato al raggiungimento degli obbiettivi, le possibilità di perdere alcuni elementi, di rallentare la spinta propositiva o, peggio, di avere dei lavoratori rassegnati e poco attivi può creare molti problemi. Il manager, da cui dipendono i lavoratori, dovrebbe vigilare sui rapporti di forza all’interno dei team, ma soprattutto, capire le qualità delle persone più fragili emotivamente, che possono portare comunque il loro contributo, magari importante per le doti che hanno, potendo lavorare nelle condizioni di tranquillità emotiva. Può capitare che un introverso non abbia il coraggio di proporre idee o soluzioni, oppure esegua dei lavori in modo meccanico per paura di sbagliare e di venire giudicato, non solo dal superiore, ma soprattutto dai colleghi con cui vive la quotidianità. Può capitare che una persona con bassa autostima possa seguire, facilmente e in modo corretto il flusso del lavoro, intuire migliorie e novità, ma non si sente in grado di proporre iniziative perché può sviluppare, nella sua mente, la convinzione di non essere migliore di altri nel proporre soluzioni utili, e che, quindi, se queste non fossero all’altezza delle aspettative collegiali, lo vivrebbe come un’altra sconfitta personale. Conoscere i pro e i contro dei componenti della propria squadra permette un dialogo costruttivo, empatico e senza preconcetti, che metta i lavoratori a proprio agio nel partecipare in modo creativo all’azione dell’impresa. Il manager deve saper instillare ai soggetti emergenti il rispetto per i colleghi, l’umiltà nel lavoro e la costruttiva collaborazione e, se serve, reprimere gli abusi e le discriminazioni soprattutto versi i più fragili. Il concetto, largamente diffuso, che la forza lavoro non espansiva o non apparentemente competitiva possa essere un peso all’azienda credo sia del tutto fuori luogo, inoltre credere che all’interno dei team di lavoro la soluzione naturale del “vinca il più forte” possa portare una scrematura, utile a formare gerarchie funzionali al lavoro, sia un concetto pericoloso e poco efficace. Ogni persona si può esprimere al meglio se si sente apprezzata, se riceve fiducia e se viene rispettata come individuo, prima ancora di essere un lavoratore, sta poi al manager capire, in funzioni delle caratteristiche intellettive e caratteriali di ognuno, come assegnare il giusto ruolo ai componenti del proprio team.
SCOPRI DI PIU'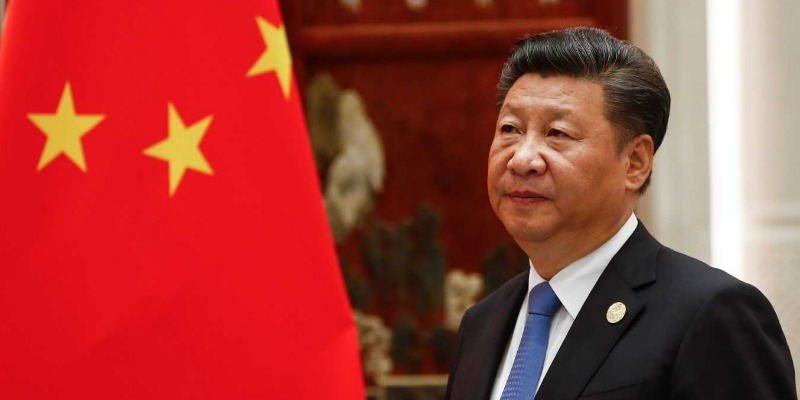
 Perché l’Economia della Cina si Sta Indebolendo? Vediamo le Cause
Perché l’Economia della Cina si Sta Indebolendo? Vediamo le CauseUn mix di fattori politico finanziari sta condizionando la seconda economia mondiale.di Marco ArezioCi eravamo abituati a vedere la crescita del PIL cinese con valori di tre o quattro volte superiori a quelli dell’Europa e degli USA, tanto da pensare che fosse un paese a se stante, dove le crisi ricorrenti che si vivono in occidente non potessero mai toccare la fabbrica del mondo. Abbiamo, negli anni, aperto le nostre porte ai prodotti cinesi, pensando di fare buoni affari comprando e rivendendo le loro merci invece che produrle in occidente. Le aziende maggiormente strutturate hanno iniziato la delocalizzazione massiccia in Cina, in modo da ridurre i costi di produzione e massimizzare i margini di contribuzione. Sono passati diversi anni per accorgerci che produrre lontano da casa poteva anche avere dei risvolti negativi sul prodotto, sulla logistica, sulla gestione del lavoro esternalizzato, che non sempre venivano compensati dai maggiori margini sulle operazioni di vendita. Oggi, la Cina ha un’immagine un po' meno lucente che nel passato agli occhi del mondo, un mercato che sta rallentando e le grandi multinazionali che si stanno guardando in giro, fuori dei confini Cinesi, per trovare nuove soluzioni produttive. Ma quali sono le cause di questo rallentamento del Dragone? Rossella Savojardo ha fatto un’analisi delle tre maggiori cause dell’indebolimento del mercato cinese, che vengono rappresentate da motivazioni politiche, economiche e sociali. La Cina eviterà la recessione sia quest’anno (+3,5% il pil) che il prossimo (+4,5%), con un’inflazione che rispetto ai paesi occidentali sarà bassa (2,8% nel 2022 e 1,9% nel 2023). Ma la forza dell’economia del Dragone nell’ultimo periodo si è affievolita e le cause sembrano essere almeno tre secondo gli esperti. La pandemia e la politica zero-Covid I casi di Covid-19 in Cina hanno segnato un nuovo aumento a oltre 31 mila contagi, un record da inizio pandemia. Questo ha di nuovo portato a lockdown generalizzati in tutto il Paese con la chiusura anche di alcuni importanti centri produttivi. Jian Shi Cortesi, investiment director Asia e Cina Equities di Gam, spiega che “il governo cinese si trova di fronte a un compromesso tra i decessi causati dal Covid e il rallentamento dell’economia. Grazie al successo delle misure di contenimento adottate in Cina negli ultimi due anni, meno dello 0,1% dei cinesi è stato infettato dal Covid e la Cina ha registrato soltanto poche migliaia di decessi (rispetto a 1 milione registrato negli Usa)”. Ciò, secondo Shi Cortesi, probabilmente rende la popolazione cinese altamente vulnerabile al Covid rispetto ai Paesi che stanno raggiungendo l'immunità di gregge. Il segmento più vulnerabile della popolazione cinese non è propenso a farsi vaccinare. In futuro probabilmente, per l’esperto, non si assisterà a un cambiamento immediato della politica cinese di zero Covid. Tuttavia, “le restrizioni sono sempre più pratiche. I lockdown generalizzati sono ora più rari. Si assiste invece a chiusure più mirate al fine di bilanciare le restrizioni Covid e l’impatto economico”. Evergrande e la crisi immobiliare Non solo Covid. In Cina a vacillare è anche il settore immobiliare anche a causa dei pericoli derivanti dal debito in sofferenza. “Tra il 2010 e il 2020 il mercato immobiliare in Cina era solido, con prezzi in aumento del 60% nelle principali cinque delle 70 città del Paese. Ciò ha portato alcuni acquirenti di case a lamentarsi dell’accessibilità economica degli immobili e il governo si è preoccupato che ciò potesse portare a una bolla immobiliare”, continua a spiegare Shi, evidenziando che per questo nel 2020 e nel 2021, alcune città in Cina hanno inasprito le regole per l’acquisto di un’abitazione nel tentativo di raffreddare il mercato immobiliare. Nel frattempo, il governo ha ordinato alle banche di rafforzare i criteri di erogazione dei prestiti alle società di sviluppo immobiliare fortemente indebitate. L’insieme di tali provvedimenti ha creato qualche problema di liquidità alle società di sviluppo immobiliare ad alto rischio, che, in qualche caso, sono risultate insolventi. "I costruttori in difficoltà hanno interrotto la realizzazione di alcuni progetti. Il sentiment è diventato piuttosto negativo per il settore, con conseguente inasprimento delle condizioni finanziarie”. Per stabilizzare la situazione immobiliare Pechino ha messo in atto politiche di sostegno sempre più incisive, ed è proprio guardando a queste ultime che l’esperto di Gam vede una probabilità molto bassa che il rallentamento del settore immobiliare porti a rischi sistematici nel sistema finanziario cinese. “Tuttavia”, continua, “è probabile che gli anni del boom del settore immobiliare siano ormai alle spalle”. Secondo alcuni esperti infatti, le vendite annuali di nuove case dovrebbero scendere a 1-1,2 miliardi di mq nei prossimi anni, rispetto agli 1,6 miliardi di mq del 2021. Ciò costituirà un freno al tasso di crescita del prodotto interno lordo del Dragone. Il problema della Cina è la disoccupazione giovanile? Ad accendere un faro su questo punto sono gli analisti di Credit Suisse, i quali ricordano che quando la forza lavoro di un paese si sta riducendo, come avviene attualmente in Cina, avere un alto tasso di disoccupazione giovanile aggrava la resistenza alla crescita del pil. “I giovani di età compresa tra 16 e 24 anni hanno una maggiore propensione marginale a consumare”, spiegano in primo luogo, “per ogni dato livello di tasso di disoccupazione globale, un tasso di disoccupazione giovanile più elevato ha quindi proporzionalmente un effetto negativo maggiore sulla crescita dei consumi”. Nel medio termine, da Credit Suisse ritengono dunque che la disoccupazione giovanile strutturalmente elevata si tradurrà in un minore potenziale di crescita, dato che questa riduce l’effettivo input di lavoro nell’economia ed esercita anche una pressione al ribasso sulla crescita dei salari. «Sulla base della nostra valutazione di vari fattori come i tassi di progresso tecnologico e la contrazione della forza lavoro, prevediamo una crescita del reddito disponibile pro capite in media intorno al 4,2% nei prossimi cinque anni, un netto calo rispetto al range dell’8-9% prima della pandemia», sottolineando dalla banca elvetica, “un tale calo della crescita tendenziale dovrebbe pertanto rimanere un vento contrario alla crescita dei consumi delle famiglie”.
SCOPRI DI PIU'
 Quali sono i Managers che Rischiano il Quiet Quitting dei propri Collaboratori?
Quali sono i Managers che Rischiano il Quiet Quitting dei propri Collaboratori?Dopo la pandemia, ed ora, nel pieno di una crisi internazionale, i lavoratori sono profondamente cambiatiStiamo attraversando un periodo di profondo stress sociale, cominciato dall’isolamento creato dalla pandemia all’interno delle nostre case, dall’utilizzo a tappeto dello smart working, dalla perdita della socialità lavorativa e da nuove regole e paure nella vita privata. Siamo stati per decenni convinti che la massima forma di realizzazione personale e sociale fosse una buona posizione lavorativa, il raggiungimento di un centro di potere, piccolo o grande che sia, una visibilità sociale positiva, frutto della propria posizione conquistata a fatica negli anni e, infine, un benessere finanziario che sottoscrivesse il nostro successo. Per questi motivi e, probabilmente, per altri del tutto personali, ci si è immolati ad una intensa attività lavorativa, dedicando tutte le proprie forze disponibili per i propri obbiettivi, ben oltre quello che poteva essere racchiuso in un contratto di lavoro. Un’idea di abnegazione al lavoro socialmente accettata e valutata in modo normale e positivo da tutti, retaggio di un concetto di laboriosità e responsabilità dell’individuo all’interno della società. Ma poi arrivò il Covid, le aziende si svuotarono, molti lavoratori furono parcheggiati a casa, in attesa che l’epidemia passasse, altri venivano organizzati per il lavoro da remoto, cambiando completamento il rapporto tra l’azienda, il lavoratore e l’ambito lavorativo. I dipendenti che hanno continuato a lavorare da casa si sono spogliati delle vesti e delle maschere che spesso si portavano con loro, la mancanza di socialità ha concentrato lo sforzo esclusivamente sul lavoro e non anche sul contesto lavorativo, creando un abbassamento delle tensioni personali. I lavoratori hanno avuto modo, attraverso l’esperienza della produttività remota, di ripensare al modello aziendale in cui vivevano, alle contraddizioni, agli sforzi profusi negli anni, alle soddisfazioni e alle brucianti amarezze subite, ai dispetti e alla marginalizzazione a volte provate, alle motivazioni passate e a quelle attuali, al risvolto economico ed al tempo che si spende dentro un’azienda rispetto a quello all’esterno di essa. Molti hanno fatto dei bilanci, hanno sperimentato nuove priorità, creato un nuovo rapporto con il denaro guadagnato, con i desideri, le ambizioni e i progetti futuri. Al rientro in presenza nelle aziende i lavoratori non erano più gli stessi di due anni prima, ognuno segnato dalle proprie trasformazioni, alcuni più profondamente per la perdita di parenti od amici, con diverse centralità rispetto al passato e nuove aspettative. Un contesto del tutto nuovo anche per i managers, che dovevano continuare a gestire la forza lavoro ed elaborare strategie per ricominciare un percorso lavorativo insieme. In questa particolare occasione il comparto dirigenziale si è distinto in due categorie: la prima che ha preso coscienza che non era possibile non considerare quello che il mondo, e i lavoratori avevano vissuto, cercando di avere un approccio empatico e comunicativo con la forza lavoro, in modo da considerare nuove strategie di gestione che tenessero conto del carico di stress accumulato, per capire come evitare dei pericolosi punti di rottura. Managers che si sono improvvisati un po’ psicologi, il cui intento era capire come fosse cambiato il singolo lavoratore, quali nuove aspettative potesse avere e quali problemi si portava con sé, quali fossero le sue ambizioni e come si potesse farle coincidere con la crescita aziendale, insomma creare soddisfazione e appartenenza al gruppo. La seconda categoria di managers ha continuato a rapportarsi e a gestire i dipendenti come se nulla fosse successo, contando sulla dedizione al lavoro della squadra, sui loro sacrifici in termini intellettivi e di tempo e spronandoli a correre come prima, anzi più di prima, visto il tempo perso durante il Covid, facendogli capire ogni giorno che dovevano ringraziare l’azienda per la conservazione del loro posto di lavoro. Questa seconda categoria non si è accorta che il suo esercito è composto di persone che non vedono più nella loro divisa l’unica soddisfazione della propria vita, cerando, giorno per giorno, una frattura sempre più ampia. La presa di coscienza di una minore motivazione che le persone trovavano in un’azienda gestita da managers distanti, senza la capacità di una concreta comunicazione, con la mancanza di ascoltare il proprio gruppo, può creare al fenomeno chiamato Quiet Quitting. Il Quiet Quitting è un atteggiamento da parte dei lavoratori che, sintetizzato, significa fare il minimo sforzo possibile entro i termini corretti del contratto di lavoro, senza più farsi trascinare nel consumo delle proprie energie mentali e di tempo per l’azienda. Un modello di approccio al lavoro che è fortemente destabilizzante per le aziende, se non lo si capisce in tempo e se non si trovano gli strumenti corretti per arginarlo ed evitarlo. Non ci sono, richiami, minacce, allusioni ad aumenti di stipendio o altri bonus che possono risolvere il problema, in quanto il lavoratore non sta violando nessuna regola e la carota dei soldi non fa più presa come un tempo. Se il manager non capisce che nella propria squadra è nata un’insoddisfazione profonda, dove i lavoratori non hanno la possibilità di esprimersi, di realizzarsi, di trarre piacere da quello che fanno, all’interno dell’azienda, i dipendenti hanno due strade: cambiare lavoro o restare applicando il Quiet Quitting. Per i quadri direttivi è importante capire che il mondo è cambiato, che l’inquietudine e le difficoltà fuori dall’azienda hanno trasformato soprattutto i giovani, la forza più propositiva e dinamica di un’impresa, e che i rapporti e gli ambiti lavorativi devono essere diversi e gestiti in modo più collegiale ed empatico.
SCOPRI DI PIU'
 Storia di un Manager Commerciale di Successo con un Lato Nascosto
Storia di un Manager Commerciale di Successo con un Lato NascostoEstroso, loquace, competente, caparbio, ostinato, trascinatore, disponibile, eclettico, coinvolgente. Ma soprattutto asocialedi Marco ArezioL’attività commerciale, in aziende di qualsiasi livello, ha necessariamente bisogno di managers che facciano della platea del mercato, un campo naturale di lotta senza esclusione di colpi. La capacità di intessere rapporti personali e commerciali, di incontrare potenziali clienti per convincerli a diventare parte della propria azienda, l’esposizione in prima persona durante meetings e fiere, facendosi portavoce del proprio gruppo di lavoro o della propria società, portano ad identificare un manager dotato di un’attitudine alla comunicazione, all’empatia verso il mondo e a suo agio con la gente. E’ uno stereotipo professionale questa figura? Forse no, infatti, il carattere ti porta, spesso, a scegliere il tuo ambito lavorativo per una sorta di minore frizione verso le attività in cui ci si inserisce. Ma non sempre è così, ci sono figure manageriali, anche di successo, che sono vincenti nelle attività commerciali, dove il contatto con i clienti è costante e dove la collaborazione con la propria squadra di lavoro si fa sul campo, in gruppo e ben motivati, ma che hanno un carattere schivo, asociale a volte misantropo. Sembra un assurdo eppure è possibile, un manager che ha ben presente non solo le strategie di vendita, di relazione, di persuasione, di creazione del feeling giusto con i clienti o potenziali tali, ma fa anche di sé stesso una strategia di marketing. Ha ben presente quali sono i suoi passi per raggiungere gli obbiettivi che si è prefissato o che ha ricevuto dall’azienda, passi che lo porta a cene, visite in aziende, colloqui, momenti di incontro collettivi, meetings, esposizione a platee di persone e molte altre manifestazioni di contatto con il pubblico. Questa è la sua strada, il suo programma, i suoi passi da compiere per raggiungere i budgets, un percorso del tutto innaturale per lui, dove vive con ostinata riluttanza cenare con i clienti, parlare della propria e della loro vita, condividere inviti e momenti conviviali extra lavorativi, stringere mani alle fiere e ascoltare chiunque, parlare in pubblico, tenere corsi e seminari. Ogni momento di condivisione sociale è sofferto, ogni viaggio è un peso, ogni riunione con collaboratori e clienti è un dovere oneroso. Ma tutto questo non lo porta a incrinare il suo successo professionale, un’avanzata programmata nei modi, nei tempi, nell’intensità che si è imposto, cliente dopo cliente, incontro dopo incontro, fiera dopo fiera. Lui stesso fa parte della propria strategia professionale, lui stesso è un cliente da incontrare, convincere e inglobare nel suo risultato strategico. L’autodisciplina e la severità verso sé stesso non ne hanno modificato il carattere, ma hanno creato uno sdoppiamento della personalità, creando una figura che opera come un manager rilassato, disponibile in consessi di persone e pienamente a suo agio, che convive con una persona che si sente un pesce fuor d’acqua, che ama la solitudine, il basso profilo e i fari spenti della ribalta. Un’attività di successo che può essere molto logorante per chi la esercita e che, dopo un periodo più o meno lunga di resistenza ostinata, di solito si esaurisce per consunzione.
SCOPRI DI PIU'
 Grazie delle sue Idee: Riporterò alla Direzione e le Faremo Sapere
Grazie delle sue Idee: Riporterò alla Direzione e le Faremo SapereQuando gli anelli deboli della catena di comando non permettono la crescita degli juniors managersdi Marco ArezioDopo i lunghi periodi di studi universitari e, talvolta, reduci da un master di specializzazione, i giovani managers sono ansiosi di misurare le loro capacità, sviluppare le loro ambizioni e raggiungere i loro obbiettivi professionali. Spesso trovano occupazioni in aziende già strutturate, in cui la catena di comando è abbastanza lunga, i passi per salirla non sempre banali e la competizione tra colleghi sempre accesa. Un buon campo di prova per misurare le proprie capacità, sviluppare competenze e, a volte, proporre novità che possano portare beneficio all’azienda, attraverso un occhio nuovo, non compromesso dalle abitudini di lavoro interno. Lo junior manager che avesse sviluppato soluzioni interessanti, magari da approfondire ulteriormente, o avesse trovato delle inefficienze da risolvere per migliorare nella catena del lavoro, si rapporterà con il proprio manager da cui dipende. Dovrà sviscerare nei dettagli il processo di miglioramento studiato, o i difetti della linea di lavoro che secondo lui potrebbe essere implementata, o portare delle efficienze nella circolazione delle attività, o suggerire cambiamenti di strategie commerciali, di marketing, degli acquisti o in altri ambiti in cui ha focalizzato il proprio interesse. Le buone idee, in certe aziende, possono pesare quanto quelle negative, nel senso che possono dare fastidio a chi le riceve, che deve, a sua volta, proporre alla catena di comando sopra di lui. Non stiamo in questo caso ad analizzare il comportamento di un manager che, sicuro delle sue competenze e del proprio ruolo, incentiva gli juniors managers a sviluppare iniziative che possano essere degne di nota da proporre in ambiti più alti dell’azienda. Oggi ci occupiamo del manager intermedio, che teme il dovere veicolare iniziative diverse dalla propria routine, che possano mettere in discussione l’ambito di lavoro e di controllo che ha esercitato, nel tempo, sul suo posto di lavoro. Il trasferimento della proposta dallo junior manager al responsabile intermedio, avviene normalmente attraverso una profonda esplicazione dei dettagli della stessa, dove spesso, ascoltandola, vuole sapere i legami interni ed esterni all’azienda, gli strumenti necessari per gestire la novità, quali ambiti aziendali dovrebbe toccare e come potrebbe cambiare il suo lavoro e la sua tranquillità. Un manager di questo tipo ascolta, domanda, crea una sorta di complicità nel progetto, chiede allo junior manager riservatezza sul progetto e mantiene un rapporto di finto privilegio comunicativo con il suo sottoposto. Cerca di dargli quell’importanza che il proponente si aspetta di avere, qualificando la sua proposta e gratificandolo verbalmente per il rischio che si è assunto esponendosi a possibili di errori personali. A questo punto il manager, anello debole della catena di comando, avendo in mano tutte le carte e conoscendo esattamente la proposta, si sente in grado di elaborare una strategia che possa tornare a suo vantaggio. Se la proposta è effettivamente migliorativa, valida e importante per l’azienda, cercherà di vendere l’idea, ai suoi superiori, come una sua iniziativa, nata da un confronto, magari, con il gruppo di lavoro che dirige, attraverso il quale ha analizzato varie opinioni ed elaborato, in modo autonomo, il progetto che potrà portare un giovamento all’azienda. Potrebbe raccogliere la gratificazione dei suoi superiori e darà un minimo riconoscimento al team che, con “tanta cura dirige”, negando uno spazio di confronto tra lo junior manager e la fascia alta dell’azienda che decide. Il successo sarà del manager in primis, del gruppo di lavoro in seconda battura, facendo cadere su di sé anche il successo del gruppo che dirige. Se, in caso contrario, l’idea fosse negativa, sbagliata o non molto produttiva, terrà conto degli errori commessi dallo junior manager, anche se solo nell’elaborazione di una proposta, in modo che possa far valere, come arma di scambio, in periodi successivi gli errori del passato. Questo anello debole della catena di comando è abbastanza diffuso nelle aziende di una certa dimensione, e gli juniors managers, prima di esporsi devono cercare di conoscere il proprio superiore e capire i risvolti del suo carattere, la sincerità e la sua sicurezza nel gestire le risorse umane, senza secondi fini.
SCOPRI DI PIU'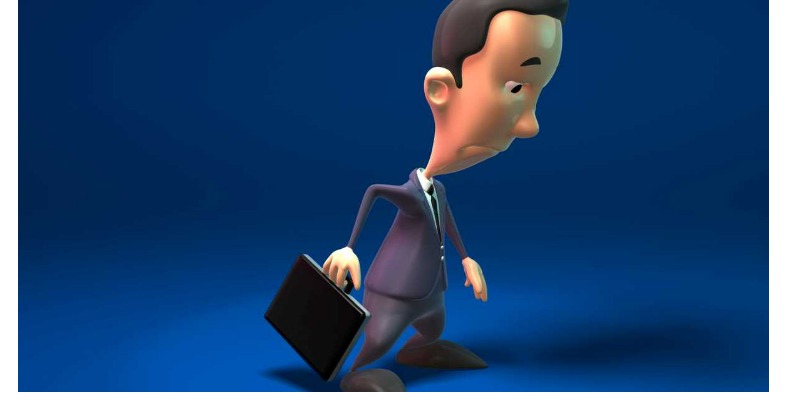
 Bassa Autostima in Posizioni Manageriali. Quali Pericoli e come Gestire il Problema?
Bassa Autostima in Posizioni Manageriali. Quali Pericoli e come Gestire il Problema?Le componenti caratteriali dei managers, a tutti i livelli, sono fondamentali per la buona salute dell’aziendadi Marco ArezioIn una realtà imprenditoriale moderna ed efficiente, di qualsiasi dimensione essa sia, la componente umana fa sempre la differenza. Questa situazione non appare, solitamente, nella breve vita delle aziende, dove la tecnologia e i mezzi di comunicazioni digitali assicurano una parte importante del successo delle attività, ma se consideriamo un arco di tempo più ampio, in cui la concorrenza ha un certo equilibrio in campo, entrano in gioco le risorse umane a fare la differenza. Una volta acquisita una certa posizione nel mercato, ci si deve confrontare con le altre realtà imprenditoriali, cercando di rimanere il più a lungo possibile in una situazione di relativa competitività e sopravvivenza aziendale. Le risorse umane, attraverso le loro catene di comando, portano motivazioni, idee, impegno, dedizione e forza al marchio, imprimendo piccoli ma costanti scostamenti di posizione tra azienda e azienda. Questi piccoli successi o insuccessi sono determinati dalla qualità dei componenti dei team aziendali che, attraverso il loro impegno, la loro capacità e il loro singolo carattere, determineranno miglioramenti o peggioramenti delle posizioni sul mercato. Il carattere dei managers gioca un ruolo fondamentale, a tutti i livelli di comando, non solo quelli apicali, ma molto spesso, quelli intermedi, hanno un ruolo fondamentale. I teams di lavoro hanno leaders che devono saper indirizzare i componenti, spronarli, consigliarli e buttarsi nella mischia con loro, mantenendo la leadership, creando un clima positivo e carismatico che galvanizza il lavoro. Deve saper premiare e punire, con la giusta moderazione ed imparzialità, i componenti del team senza eccedere in favoritismi o perdoni eccessivi, così da dare un’immagine equidistante del suo lavoro e sottolineando l’importanza del gruppo prima che del singolo. Questa azione sottintende un carattere del manager sicuro e risoluto, flessibile ma imparziale, determinato ed indipendente, che ha ben chiaro quali siano gli obbiettivi che gli sono stati affidati dall’azienda. Ma cosa succede se in una posizione di leader troviamo una persona poco sicura di sé? Il primo problema da affrontare è la sua necessità di continue conferme della legittimazione sua posizione, sia nei confronti dei superiori che delle persone che dal lui dipendono. Se nel primo caso, a volte è meno impattante, invece, la ricerca di conferme tra i collaboratori che deve dirigere crea una commistione di ruoli e un indebolimento della sua posizione. Il leader insicuro ha bisogno di un gruppo di collaboratori che lo elogino, che lo rassicurino, che lo facciano sentire al centro del progetto e che colmino quella sua mancanza di sicurezza. Questa situazione però, spesso spacca i gruppi di lavoro, in quanto ci sono collaboratori che si aspettano di essere guidati e protetti dal manager e non il contrario, mettendo in cattiva luce chi crea un rapporto di eccessiva confidenza con i leaders. Inoltre, capita spesso che durante le difficoltà a raggiungere gli obbiettivi previsti dall’azienda, questa punti il dito sul leader del gruppo che, per tutelarsi, non proteggerà l’intero team, ma potrebbe scaricare le colpe verso quella parte di persone che non lo sostengono apertamente come lui vorrebbe. Qui scatta il meccanismo contrario per cui il leader cerca di difendersi, assecondando i suoi superiori, al fine di salvaguardare la sua posizione a discapito degli altri. Passata la tempesta il manager insicuro metterà, probabilmente, al margine le persone a lui non favorevoli, puntando solo su chi lo sostiene, in quanto, spesso, rimane una persona rancorosa, che vorrebbe avere un appoggio esteso ed incondizionato che lo rassicurasse. Si creeranno rapporti ambigui, non sinceri, piccole vendette, un certo lassismo, una strisciante rassegnazione a fare il minimo indispensabile da una parte del team, creando inefficienza, perdita di competitività e valore aziendale. Per superare questi rapporti dolorosi e inefficienti per l’azienda è necessario creare gruppi di lavoro o di ascolto, in cui vengano mischiate le risorse umane, seguiti da leaders che abbiano competenza con la gestione delle risorse umane o abbiano una estrazione di carattere psicologica e relazionare, in modo da liberare le persone, attraverso il confronto su altri temi, della paura di venire allo scoperto. Questo serve per indagare i lati positivi e quelli negativi o pericolosi che aleggiano nei gruppi di lavoro dell’azienda, in modo da raccogliere le maggiori informazioni possibili, confrontarle, incrociarle e intervenire.
SCOPRI DI PIU'
 Il Cortocircuito Energetico delle Cartiere: Come Uscirne?
Il Cortocircuito Energetico delle Cartiere: Come Uscirne?Il costo del gas è sempre più alto, l’Europa tentenna sulle soluzioni. Una cartiera Italiana ha deciso di risolvere il problema da soladi Marco ArezioIl comparto della carta ha attraversato, in anni recenti, molte prove dolorose, nelle quali ha sempre cercato di mantenere dritta la barra facendo leva su risorse proprie, l’internazionalizzazione, la diversificazione ed l’eccellenza. Oggi, dopo il Covid, la mancanza di materia prima, i prezzi alle stelle per gli ormai conosciuti problemi sulla catena di approvvigionamento, è entrato a gamba tesa l’esplosione dei prezzi del gas. Problema non sempre risolvibile, questa volta, dall’estro e dalla capacità imprenditoriale dei managers aziendali, in quanto l’energia è un bene primario che si compra e si utilizza direttamente, ma che ricopre, settimana dopo settimana, un peso sempre più importante nei costi di produzione. Costi che incidono sul prodotto semilavorato o finito in modo esponenziale, con difficoltà nelle vendite e nella catena di produzione e consegna dei beni. Oggi, il cliente finale, è abituato a sentirsi dire che il prezzo è aumentato, ma da domani si sentirà dire anche “non so quando posso produrre e consegnare la merce”, perché l’approvvigionamento di energia, oltre ad essere ingestibile economicamente, diventa difficile da programmare, in quanto gli stessi operatori dell’energia sono in difficoltà nella vendita. Senza energia non si fa business, e senza business non servirà più l’energia, in quanto, molte aziende sono seriamente a rischio di chiusura e con esse la filiera da cui dipendono. Per uscire da questo corto circuito è necessario ed auspicabile che si possano trovare le risorse, anche tramite il PNRR, per rendere energeticamente indipendenti le grandi fabbriche produttrici, attraverso l’autoproduzione di energia rinnovabile. Un esempio in merito ce lo sta dando la cartiera Burgo che ha deciso di percorrere questa strada attraverso l’ampliamento della produzione di energia solare nei propri stabilimenti, attraverso un nuovo parco fotovoltaico da 12 Mw e la progressiva dismissione dell’utilizzo di combustibili fossili. Inoltre, al fine di proseguire la strada intrapresa dal mercato che riguarda la riconversione del packaging di plastica con quello in carta, la direzione ha sul tavolo di alimentare le fabbriche anche con l’idrogeno verde. In attesa dei bandi del PNRR che finanzierà il progetto dell’idrogeno, le macchine e le turbine della Burgo sono già pronte per essere alimentate a biofuel e idrogeno e continuerà, da parte dell’azienda gli investimenti sul fotovoltaico nelle varie fabbriche. La necessità di affrancarsi dalla dipendenza del gas sarà la chiave per la sopravvivenza delle cartiere, ma anche delle altre aziende energivore, come il settore dell’acciaio, della chimica, della plastica e di molti altri settori.
SCOPRI DI PIU'
 Come Trattenere in Azienda i Migliori Collaboratori
Come Trattenere in Azienda i Migliori CollaboratoriPorsi il problema di come trattenere le migliori risorse umane è indice di attenzione verso la propria aziendadi Marco ArezioIl mondo del lavoro si sa è sempre stato fluido, sia in situazioni di prosperità che di crisi, in quanto sono sempre le persone che traghettano le aziende, in qualsiasi condizione si trovi il mare, calmo o tempestoso. Se da un lato le professionalità meno qualificate o meno collaborative sono un po' in balia delle situazioni economiche interne ed esterne, quelle potenzialmente migliori possono essere una risorsa in qualsiasi condizione si possa trovare l’azienda. Ma i futuri leaders sono capricciosi, attenti alle dinamiche interne, ambiziosi, sono facilmente disposti a sgomitare, ma anche a sacrificarsi infondendo all’azienda spinte importanti. Sono sempre un po' irrequieti, giudicano e fanno paragoni, mettono sotto esame i collaboratori e i diretti superiori, possono essere fuori dagli schemi e assetati di sfide, sono dinamici e competitivi. Sono persone ricche di potenzialità, ma devono avere un contesto lavorativo che li comprenda, li faccia crescere, gli dia soddisfazioni e riconoscimenti, costantemente nel tempo, perché sono un po' narcisi. I managers da cui dipendono devono accorgersi delle loro potenzialità e devono saper valutare, caso per caso, i rischi di perderli, perché queste figure professionali cercano soddisfazioni nel mercato. Non tutte sono uguali e non tutte sono alla ricerca di affermazioni con la stessa intensità. C’è chi cerca la progressione del proprio stipendio come autocertificazione delle proprie qualità professionali, chi cerca maggiori responsabilità, chi cerca entrambi, chi un percorso di formazione manageriale di alto livello. Tutte aspettative che non si possono soddisfare sempre con il vecchio adagio dell’incremento di stipendio, in quanto non tutti lo mettono in cima alle proprie priorità, anzi direi che se un manager punta solo su quello può incorrere in diversi rischi. Come si sa, gli ambiziosi che rincorrono salari sempre più alti e ne fanno una priorità della loro vita lavorativa, difficilmente si accontentano, nel tempo, dei gradini che hanno raggiunto. Sono gli elementi più difficili da trattenere in quanto hanno, normalmente, un ego piuttosto importante e la soddisfazione del raggiungimento di un aumento, muore dopo poco tempo, in quanto l’aumento stesso certifica in loro il riconoscimento della “necessità” dell’azienda nel trattenerlo. Si possono sentire indispensabili e riconosciuti come elementi importanti e quindi ne possono fare una questione di continua trattativa con l’azienda, sondando anche il mercato per valutare quando o come richiedere il prossimo aumento. Le risorse umane che cercano maggiori responsabilità sono quelle che ricavano dal proprio lavoro una soddisfazione personale, alimentano la loro autostima nella consapevolezza del loro ruolo nella società. Si riconoscono utili, ma non per forza indispensabili, al progresso dell’azienda e considerano le loro competenze un collante nei rapporti con la società, ricercando all’interno della stessa, o sul mercato se non ve ne fossero le opportunità, posizioni di prestigio. Sono persone normalmente meno impulsive, più equilibrate, ma sempre ambiziose e necessitano di trovare quello che cercano, in un arco di tempo ragionevole, difficilmente barattano il loro futuro e, se delusi, sono disposti a rivolgersi al mercato. Esistono poi elementi che cercano uno sviluppo professionale legato al miglioramento delle competenze manageriali, che sono disposti a barattare delle affermazioni economiche nel breve-medio periodo con un percorso di formazione, anche internazionale, che possa diventare un biglietto da visita indiscutibile per il futuro. Anche queste sono figure professionali che si possono perdere facilmente se, assunti, non gli si offre un percorso di crescita di un livello importante, con il conseguente rischio di perderli in breve tempo. Come abbiamo visto le risorse umane da assumere o presenti in azienda hanno esigenze diverse e i managers, se vogliono trattenerli in azienda devono incominciare a capire come sono di carattere, quali siano le loro ambizioni e quali strade da prendere, per creare loro un clima di soddisfazione per trattenerli.
SCOPRI DI PIU'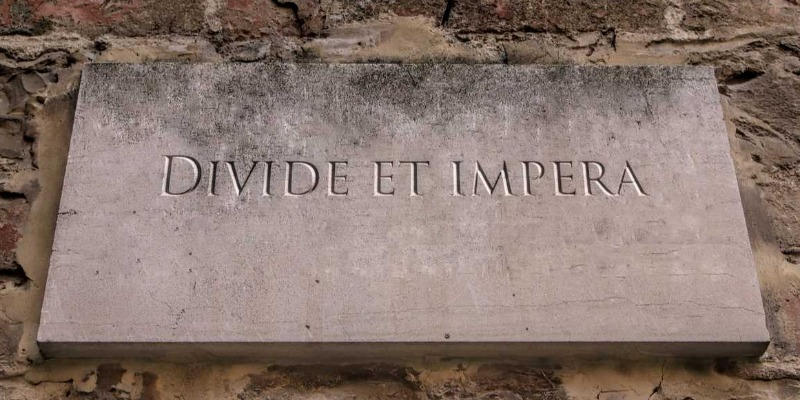
 Divide et Impera: non Sempre Funziona in Azienda. Vediamo Perché
Divide et Impera: non Sempre Funziona in Azienda. Vediamo PerchéLa strategia di mettere in competizione tra loro le risorse umane può avere dei limiti e dei pericolidi Marco ArezioNel mondo del lavoro la competizione è una cosa naturale e sana, dove i colleghi cercano di competere per migliorare la loro posizione lavorativa, economica e di prestigio. Ci sono persone più ambiziose che vedono precisamente i loro obbiettivi e cercano a tutti i costi di raggiungerli, mentre altre cercano di avere rapporti stabili, rutinari evitando scontri e dispute. La capacità del manager di valutare queste differenze caratteriali all’interno del team di lavoro, è importante per finalizzare i propri obbiettivi e per mantenere una stabilità e una continuità nel gruppo. La prima analisi da fare riguarda il numero degli elementi definiti “ambiziosi” rispetto agli altri e la qualità della loro determinazione, in modo da valutare le eventuali ripercussioni nel team. In ogni gruppo di lavoro si forma naturalmente una piramide gerarchica, anche non dichiarata, dove uno o più elementi trascinano la squadra verso gli obbiettivi aziendali. Il manager dovrebbe valutare le conseguenze di questa o queste leaderships, inclusi i risvolti produttivi e relazionali che tali elementi potrebbero creare. Per fare questo è bene conoscere gli aspetti caratteriali dei componenti della squadra, in quanto la convivenza tra gli elementi del team è un fattore da tenere in considerazione per i risultati finali. I collaboratori possono accettare di buon grado imposizioni fatte dal manager da cui dipendono gerarchicamente, inserito ufficialmente nell’organigramma aziendale, ma possono non gradire gli ordini comunicati da un collega considerato al loro stesso livello. In situazioni simili si vedono spesso managers che seguono strategie di gestione dei collaboratori differenti. Una strategia può seguire il motto antico divide et Impera, che tende a lasciare nel gruppo più di un leader, con la conseguenza di vedere crescere la competitività tra i colleghi, le lotte dichiarate o sotterranee, la creazione di fazioni più facili da controllare e che non intaccano il suo potere. Il manager in questo caso interviene, normalmente, solo quando il tenore delle dispute superano un certo limite o la situazione, legata ai risultati aziendali, impone un intervento per spronare gli elementi. E’ scelta solitamente da managers, le cui ambizioni verso i risultati aziendali e il prestigio personale superano qualsiasi necessità di rapporti umani, tendendo a distribuire in modo parsimonioso riconoscenze mirate al mantenimento di un gruppo efficiente ma conflittuale. La seconda strategia tende invece ad eleggere un leader nel gruppo, che sia ambizioso ma non narciso, che si preoccupi di coinvolgere i colleghi nei successi e nel prestigio dei risultati, imparando a fare il manager. In questo modo si avrà un gruppo più coeso, forse un po' meno competitivo, ma più efficiente nel lungo periodo, con un turnover delle risorse umane più basso e meno dispersione di conoscenze. Il manager che segue questa strada è coinvolto umanamente con le persone del proprio team, le frequenta, è empatico e collaborativo, corretto e affidabile. Si crea un clima di fiducia reciproca, di chiarezza e distensione che spronano i lavoratori ad impegnarsi per mantenere uno status quo lavorativo, apprezzabile e di valore. Consigliare quale sia la strategia migliore, tra quelle che abbiamo visto, per la gestione della forza lavoro è del tutto personale, in quanto il carattere del manager influenzerà la scelta. Non si può dire, come si crede, che quella del Divide et Impera possa essere sempre la migliore, in quanto bisogna valutare i rischi che l’estrema competizione tra i lavoratori possa portare. I pericoli possono venire da forme di invidia che potrebbero spingere, alcuni lavoratori non considerati o esclusi dalla competizione, a forme di ritorsioni, più o meno blande, con la compromissione dei risultati generali. Un altro pericolo è l’abbandono del posto di lavoro da parte di alcuni elementi che mal sopportano un ambiente teso e conflittuale, con il rischio di un turnover alto e la perdita delle conoscenze acquisite dai lavoratori che lasciano, con le difficoltà dell’azienda a trovare elementi validi.
SCOPRI DI PIU'
 Gestione dei Pallets in un Magazzino con Bassa Rotazione. Quali Problemi?
Gestione dei Pallets in un Magazzino con Bassa Rotazione. Quali Problemi?Come influisce la scelta del pallet in legno o in plastica in un magazzino a bassa o bassissima rotazionedi Marco ArezioIl manager della logistica aziendale ha ben presente i flussi dei materiali che arrivano dalla produzione o dai fornitori, e i tempi di sosta nei propri magazzini prima che vengano venduti.Conoscere il movimento delle merci in un magazzino non è fondamentale solo per l’ufficio acquisti, per programmare l’ingresso delle materie prime o dei semilavorati o dei materiali commercializzati, ma diventa importante anche per l’ufficio commerciale, per sapere quale prodotto è in pronto per la vendita e in quanto tempo il cliente potrà ricevere ciò che ha comprato. Inoltre, l’ufficio amministrativo vede i flussi di magazzino trasformati in liquidità circolante o non circolante, con conseguenza sugli impegni finanziari dell’azienda. Molte cose girano intorno alla logistica di un’azienda e la velocità di rotazione del magazzino implica alcune considerazioni importanti per chi si occupa di questa attività. Oggi vorrei analizzare un aspetto che riguarda la durabilità degli imballi dei prodotti in un magazzino a bassa e bassissima rotazione, specialmente per quelle aziende che devono produrre ampi stocks di merce, secondo campagne stabilite o per determinati impegni sugli impianti o per avere una gamma di prodotti disponibili molto ampia. Non potendo generalizzare, considerando la grandissima quantità di articoli imballati diversi tra loro, prendiamo in considerazione un bene durevole, contenuto in un Big Bag su bancale in legno. Supponiamo, inoltre, che il materiale prodotto o acquistato venga depositato in un’area esterna, non coperta, esposto agli agenti atmosferici. Per motivi economici spesso si prendono in considerazione i bancali in legno, nuovi o usati, per depositare in magazzino i big bags con la merce da vendere, senza preoccuparci troppo dell’origine del legno e della sua situazione fitosanitaria, a meno che non venga espressamente richiesta per spedizioni in determinati paesi. In un magazzino a media od alta rotazione, la qualità del legno che compone il bancale è normalmente controllata principalmente per una questione di resistenza meccanica del bancale. Si controlla la robustezza a discapito della durata, in quanto, in questa condizione di magazzino, è un parametro non totalmente necessario. Se, invece, il magazzino ha una bassa o bassissima rotazione delle merci, la durabilità del bancale in legno diventa un aspetto da controllare attentamente. Infatti, la permanenza dei pallets in magazzino, non solo sono soggetti agli agenti atmosferici, ma può succedere di dover anche considerare la presenza di funghi, batteri o insetti che potrebbero vivere all’interno del bancale, riducendone la qualità. Soprattutto è da tenere presente la dimensione del magazzino, espresso in numero di bancali depositati e la permanenza degli stessi nel tempo. Maggiori saranno questi due numeri e maggiori saranno i rischi sulla durabilità del legno. I bancali in legno sono soggetti all’attacco di numerosi elementi che tendono a nutrirsi del legno stesso, o a colonizzare la struttura con il pericolo di infettare i pallets ancora sani. I più comuni organismi e parassiti che possiamo incontrare sono: Lictidi Bostrichidi Buprestidi Nematodi Curculionidi Anobidi Siricidi Cerambicidi Edemeridi Isoptera Scolitidi L’acquisto di pallets non trattati dal punto di vista fitosanitario, comporta il rischio, con il tempo, di rendere possibile una contaminazione generale del magazzino, con un possibile aumento dei costi di stoccaggio e movimentazione per l’eventuale sostituzione dei bancali ammalorati, senza contare la probabilità di non poter garantire la stabilità del big bags al momento della sostituzione. Il problema si può risolvere acquistando, sempre, bancali a cui è stato effettuato il trattamento fitosanitario termico, o chimico (a spruzzo, ad immersione o a pressione), o la fumigazione o altri interventi previsti dalla certificazione IPPC. Se l’acquisto di bancali trattati dal punto di vista fitosanitario aiuta ad aumentare la loro durabilità rispetto ai parassiti e gli insetti, c’è anche da considerare la variabile della pioggia, della rugiada, del gelo o di tutte quelle condizioni atmosferiche che permettono al bancale in legno di assorbire l’acqua. In questi casi, in un magazzino a bassa o bassissima rotazione, può essere consigliabile prendere in considerazione un bancale di plastica, che non è soggetto alle problematiche meteorologiche, escludendo il gelo e il sole. Per ovviare a questi due inconvenienti è importante informarsi sulla qualità della plastica utilizzata per iniettare il bancale, che dovrà avere una sufficiente elasticità, oltre che una buona resistenza alla compressione e flessione. Inoltre, per questo tipo di magazzino, è consigliabile acquistare bancali in plastica che contengano un master anti U.V. di almeno 12 mesi, che si può ottenere inserendo, durante la produzione, specifici additivi o con aumentando il carbon black nell’impasto polimerico, se il bancale sarà nero.
SCOPRI DI PIU'
 Come Capire il Carattere di un Manager Attraverso l’Osservazione dei suoi Collaboratori
Come Capire il Carattere di un Manager Attraverso l’Osservazione dei suoi CollaboratoriI lavoratori che sono selezionati dal manager danno interessanti spunti per fare un quadro della sua personalitàdi Marco ArezioCi sono aziende in cui la selezione dei collaboratori non è affidata ad un ufficio del personale, o scelti direttamente dal proprietario, ma spesso sono selezionati e scelti direttamente dai managers di area. Un direttore commerciale può selezionare i venditori, i collaboratori del back office, del settore post vendita e a volte dei responsabili marketing. Un direttore amministrativo potrebbe scegliere i componenti dell’ufficio contabilità, di quello delle paghe, del settore di controllo ecc.. Dove troviamo delle figure apicali, che potrebbero coinvolgere anche il direttore generale che hanno la responsabilità dell’azienda per conto del proprietario o dei proprietari, è interessante analizzare i collaboratori per capire come sono, caratterialmente il propri superiori. I managers possono essere competenti e determinati, ma possono avere due tipologie di carattere: • sicuro di sé stesso • insicuro di sé stesso Vi chiederete come possa essere importante il carattere personale di un manager se sono riscontrate e avvalorate la loro capacità e determinazione nell’affrontare il lavoro. Il carattere conta molto, invece, in quanto i requisiti che un manager sceglie durante le selezioni dei propri collaboratori, a parità di lavoro, sono decisamente diverse e, nello stesso verso, conoscendo i caratteri dei dipendenti scelti dal manager, è abbastanza facile farsi un quadro della sua personalità. Il manager sicuro di sé cerca delle figure capaci di reggere lo stress del lavoro, che abbiano un carattere forte, che accettino lo scontro di opinioni, che siano propositivi nei cambiamenti, leali con gli altri collaboratori, non accettino scorciatoie, che sappiano dire quando sbagliano e riconoscere anche i successi degli altri. Il collaboratore deve sapere fare squadra, non ha bisogno dell’approvazione degli altri e nemmeno del proprio superiore e ha un rapporto aperto ma corretto. Il manager sicuro darà ampie deleghe nelle attività, senza la paura che qualcuno lo possa scavalcare, farà lavorare al meglio la squadra e darà loro le giuste soddisfazioni, mettendosi a volte anche in ombra. Il manager insicuro di sé seleziona i propri collaboratori che abbiano una passione per il lavoro, diretto da altri, capaci ma non intraprendenti, che abbiano idee ma non il carattere di farle valere in un gruppo aperto, che siano psicologicamente un po' manipolabili in modo da creare un rapporto di sudditanza e di necessità verso il capo. Il manager insicuro non selezionerà figure che possono metterlo in ombra con i suoi superiori, che possano avere delle idee vincenti prima di lui, che possano fare squadra con gli altri lavoratori, ma tenderà a verticalizzare la piramide del suo potere per gestire e controllare ogni posizione a sé. Non delegherà molto e cercherà di ridurre le autonomie lavorative per paura di essere un giorno scavalcato, tenderà a mettere in competizione personale i collaboratori, gestirà divisioni e litigi, dissapori e vendette. Considererà ogni sforzo che le fazioni del gruppo spenderanno per contendersi la visibilità verso il manager come una forma di controllo indiretto e non si preoccuperà delle tante energie perse. Le aziende che selezioneranno, a loro volta questi managers, devono, per il bene dell'impresa, cercare di capire il loro carattere perché, la sicurezza o l’insicurezza di sé, crea dei reparti aziendali con performaces nel tempo molto diverse.
SCOPRI DI PIU'
 Misantropia da Smart Working: Come Coinvolgere i Collaboratori?
Misantropia da Smart Working: Come Coinvolgere i Collaboratori?Lo smart working ha alimentato una socialità lavorativa immateriale come un grande social networkdi Marco ArezioIl periodo del Covid ha profondamente rivoluzionato il mondo del lavoro, non solo fisicamente, con l’adozione dello smart working in modo massiccio, ma anche mentalmente, con i lavoratori che hanno continuato a svolgere le loro mansioni da casa, in una sorta di azienda distribuita sul territorio. Le tecnologie che hanno permesso tutto ciò erano in nostro possesso da molto tempo, ma ben pochi le utilizzavano, come poi è avvenuto durante la pandemia, con gli uffici generalmente chiusi o bassamente presidiati, e il lavoro che continuava dalle singole abitazioni. La rivoluzione tecnologica del lavoro a distanza non sarebbe partita così velocemente e massicciamente se non avessimo dovuto farlo per forza, complice una serie di abitudini consolidate che hanno sempre visto, come essenziale, la socialità aziendale per produrre e controllare le attività da parte della catena aziendale. L’impostazione del lavoro pre-covid era, generalmente, differente in base alla dimensione aziendale, maggiore era la sua grandezza e la sua internazionalizzazione e più facilmente si impiegava lo smart working, viceversa, più piccola e più localizzata era l’attività e minore attitudine vi era al lavoro da remoto. Con l’effetto pandemia c’è stato un rimescolamento delle abitudini aziendali, con l’utilizzo in modo trasversale di un modello di lavoro non concentrato in azienda ma prevalentemente da casa. Le aziende si sono accorte che, salvo casi particolari, le attività potevano continuare a essere svolte senza grossi problemi, che il modello della delocalizzazione del lavoro poteva avere un effetto positivo sui costi di gestione degli immobili e che il volume di ore lavorate non calava, anche senza il controllo fisico del lavoratore, ma, in molti casi, aumentava. I collaboratori aziendali, dopo un primo periodo di assestamento, hanno trovato un equilibrio tra le attività da svolgere e l’ambiente domestico, trovando a loro volta dei vantaggi, anche economici in questo processo, che riguardavano il risparmio economico sui viaggi casa-lavoro, sull’abbigliamento e tal volta sui costi dei pranzi di lavoro. Con il passare dei mesi si è venuto a creare un modello di lavoro dove la socialità era stata messa da parte, abituandosi a considerare le ore lavorate solo come una prestazione oraria in un’azienda che era diventata immateriale. Alla fine della pandemia, molte aziende hanno mantenuto il modello del lavoro a distanza, mentre altre hanno fatto rientrare i lavoratori negli uffici per riprendere le attività in presenza. Il rientro in ufficio non è stato per tutti una cosa semplice, in quanto psicologicamente era come iniziare un lavoro in una nuova azienda, riallacciare rapporti tra i colleghi, conoscerne di altri e misurarsi con i cambiamenti caratteriali e psicologici che il lungo lavoro da casa portava con sé. La socialità dei componenti degli uffici non è più tornata quella di prima, quei meccanismi che esistevano per un certo tempo non torneranno velocemente, complici fattori di sicurezza che tendono ad isolare i lavoratori anche all’interno degli uffici. Mascherine, divisori tra le postazioni e le scrivanie, rotazione di orari, riduzione delle attività delle mense o degli incontri nella pausa pranzo, trasporti da e per il luogo di lavoro regolamentato, sono le nuove barriere. Si è, a volte, sviluppata una certa misantropia professionale attraverso la riduzione dei contatti umani in ufficio, la minimalizzazione delle visite ai clienti o fornitori, preferendo le videoconferenze e una certa diffidenza di fondo verso attività che comportino la presenza di altre persone nella tua area di sicurezza. Questo mix composto da misure di sicurezza fisiche e psicologiche avranno bisogno di un tempo medio lungo per essere risolte, perché i collaboratori che soffrono di forme di misantropia lavorativa, vivono uno stress nel sopportare la vicinanza di altre persone e l’idea di riprendere attività lavorative che comportino assembramenti o viaggi di lavoro, salendo si aerei, treni, andare in alberghi e ristoranti. E’ importante capire chi soffre di queste problematiche per cercare di risolvere gli inutili contatti lavorativi diretti, che si usavano nel passato, attraverso l’uso di nuove tecnologie comunicative. Ma è anche importante ricreare una socialità lavorativa, quando necessaria, aiutando anche psicologicamente chi fa più fatica ad accettare luoghi e momenti comuni di lavoro. Foto:Il MisantropoDipinto di Pietrel Bruegel il vecchioTempera su Tela cm. 86x85Museo di Capodimonte Napoli
SCOPRI DI PIU'
 Relazioni Sentimentali in un Team di Lavoro: Quali Effetti sui Risultati
Relazioni Sentimentali in un Team di Lavoro: Quali Effetti sui RisultatiCome un Flirt in un team aziendale potrebbe influire sui risultati lavoratividi Marco ArezioChe siano aziende grandi, in cui esistano diversi gruppi di lavoro divisi per differenti attività interne, che di piccole aziende, in cui un unico team si occupa delle attività aziendali, la componente umana è il motore di qualsiasi impresa. Le persone lavorano sempre a stretto contatto e dividono, non solo gli obbiettivi di budget che l’azienda ha deciso anno per anno, ma anche gli spazi e il loro tempo, attraverso una socialità che permette loro di portare avanti le attività per cui sono state assunte. Come in ogni ambito sociale all’interno dei teams di lavoro si devono creare degli equilibri tra le persone, linee di confini non visibili, gerarchie a volte non scritte e il confronto con reazioni caratteriali differenti. Come in una squadra di calcio, basket o di un altro sport collettivo, una grande scommessa che fa il coach, nel nostro caso il dirigente o il responsabile della squadra, è lavorare per amalgamare i componenti del team, smussare i caratteri, accrescere la fiducia collettiva, aumentare la competitività, in pratica applicare quello che è chiamato “gioco di squadra”. Sembra semplice scegliere un certo numero di collaboratori, senza conoscerli, metterli a lavorare insieme e pretendere dei risultati dopo un certo periodo, dando per scontato che questi arrivino nelle quantità e nella qualità desiderata. E’ pur vero che qualcuno vince alla lotteria, a fronte di milioni di perdenti, ma in azienda l’azzardo eccessivo ricade sempre sul leader. Questo dovrebbe preoccuparsi di avere un team coeso, collaborativo, fiducioso, con obbiettivi condivisi e con relazioni interpersonali corrette e costruttive. Per realizzare un equilibrio così importante tra le persone è necessario investire tempo tra loro, conoscerne i difetti e i pregi, condividere il senso collaborativo delle loro relazioni professionali, in modo da ridurre gli individualismi innati nell’uomo e il senso di prevalenza, l’uno sull’altro, che distruggerebbe lo spirito di squadra. Per accrescere il senso di appartenenza al team e ridurre la sterile competizione individuale, che porterebbe a lotte intestine, invidie, dispetti ed azioni che si ripercuoterebbero negativamente sui risultati aziendali, è importante anche vivere insieme dei momenti di vita comune fuori dal contesto aziendale. Una gita o un programma di gite, sostenute dall’azienda, in località culturali o di svago hanno la forza di accrescere quello spirito di unione e condivisione, in un ambito in cui le difese personali sono meno rigide, le confidenze e la conoscenza delle persone si mostrano più profonde e con esse il loro legame. Cambia la percezione reciproca, spostando l’asse da un concetto di collega ad uno di persona, con la speranza che il tempo riesca a portare in azienda meno colleghi e più persone. Nei gruppi di lavoro, specialmente quelli giovani, vivono sempre speranze ed aspettative anche non professionali, dove le preferenze di tipo sentimentale sono all’ordine del giorno. Il mondo del lavoro non è differente rispetto a quello che può succedere in momenti di socialità quotidiani, dove le persone si scelgono, o sperano di farlo, perseguendo sempre la ricerca, consapevolmente o meno, di un contatto umano sotto diverse forme. Quando questo approccio dovesse diventare concreto all’interno dello stesso team di lavoro, specialmente se questo è composto da molte persone, è bene rendersi conto della situazione e mettere in conto la possibilità di un mutamento degli equilibri interni. Il flirt tra due componenti del gruppo potrebbe creare invidie e gelosie tra alcune persone che avevano probabilmente speranze reciproche verso una delle due, creando un senso di frustrazione e di rifiuto, non solo verso di loro, ma anche del gruppo stesso. Qui entra in gioco la minaccia all’armonia collettiva, in quanto esisteranno fazioni a cui l’episodio non creerà nessun effetto collaterale e, altre, che genereranno delle conseguenze. Una o più persone frustrate del team non riusciranno più, probabilmente, ad avere rapporti costruttivi e collaborativi, ma potranno, consciamente o inconsciamente, mettere in campo azioni punitive per il rifiuto subito. Questo può creare un attrito crescente tra il gruppo, senza magari capirne le motivazioni e senza poter sapere come recuperare il clima costruttivo di prima. Solo un’attenta osservazione delle singole persone all’interno del team di lavoro e la loro pregressa conoscenza personale, può indurre il responsabile a pensare che esistano motivazioni di carattere extra lavorativo che stanno minacciando il funzionamento del gruppo. Nel rispetto della privacy dei singoli, è importante incrementare l’interlocuzione personale con tutti i componenti, singolarmente, e spingerli ad esternare i loro problemi e a raccontare la loro visione delle difficoltà del gruppo. Incrociando i dati raccolti, amalgamandoli con quelli immagazzinati nel tempo, confrontandoli con un prima e un dopo, si può arrivare ad individuare le aree del problema, ponendo in atto delle azioni che disinneschino le sensazioni negative della o delle persone che stanno vivendo male il momento.
SCOPRI DI PIU'
 Come Gestire in Modo Efficace una Contestazione sul Prodotto
Come Gestire in Modo Efficace una Contestazione sul ProdottoCome Gestire in Modo Efficace una Contestazione sul Prodottodi Marco ArezioNel mondo del commercio e della produzione non si vorrebbe mai ricevere una contestazione in quanto sono situazioni sempre spinose da gestire. Da una parte c’è il rapporto con il cliente, che normalmente si cerca di coltivare in modo costruttivo sul lungo periodo e dall’altra c’è l’azienda che potrebbe aver commesso un errore. In base a come è strutturata la società produttrice o distributrice, la contestazione sollevata dal cliente viene recepita così da mettere in moto una serie di verifiche inerenti all’insoddisfazione palesata. Non è qui la sede per descrivere l’iter di controlli interni, anche perché ogni azienda segue i propri canali in base a come è strutturata, ma mi vorrei soffermare sulla gestione dell’attività di risposta verso il cliente. Fatto salvo che la persona addetta a gestire la contestazione può essere un addetto al customer service, al post vendita o una figura più tecnica, se la contestazione dovesse riguardare aspetti prettamente tecnici o ad un commerciale che ha venduto il prodotto. La delega alla gestione della contestazione dipende anche dalla dimensione aziendali e dalla possibile ripetitività e periodicità della stessa, dalle dimensioni del mercato e dal tipo di prodotti. Tra tutti, faremo un’ipotesi esemplificativa in cui rappresenteremo un’azienda media, che produce polimeri, su una fornitura gestita da un agente di vendita in un’area nazionale. In questo caso il primo a raccogliere la contestazione potrebbe essere l’agente di zona che avrà il compito di parlare con il cliente per capire i termini del problema. Nel campo dei polimeri riciclati si rende necessaria una campionatura del granulo venduto, dei parametri macchina usati ed eventualmente un pezzo del prodotto realizzato. L’agente si interfaccerà con il responsabile commerciale il quale, raccolte le indicazioni dell’agente, attiverà i controlli interni per verificare, analiticamente, quanto affermato dal cliente. In questi casi entrano in gioco alcune variabili importanti: • Tipologia della contestazione • Dimensione economica della contestazione • Importanza del cliente Tipologia della contestazione Ci sono aziende produttive che, utilizzando determinati input, possono andare incontro a possibili contestazioni sulla materia prima attraverso una casistica che già conoscono. Questo non significa che il polimero prodotto sia in ogni caso non conforme, ma che, per esempio, se utilizzato con determinate temperature macchina, determinati impianti, in determinate condizioni ambientali, qualche cliente potrebbe avere dei problemi. C’è anche il caso che effettivamente l’azienda abbia commesso degli errori o delle leggerezze, che hanno portato alla spedizione di un lotto di materiale non conforme. In questa sede non ci soffermeremo sulle tipologie di problematiche che un polimero può avere, né sul motivo per cui dalla produzione sia transitato nell’area di controllo e poi in quella logistica, senza che nessuno fosse intervenuto per segnalare un problema. Questo fa parte di un problema organizzativo che non sarà approfondito in questo momento, in quanto a noi interessa analizzare la gestione di una contestazione che in realtà già c’è. Il responsabile commerciale, che in questo caso sarà deputato alla gestione della contestazione, dopo aver verificato i risultati delle verifiche che sono venuti dalla produzione e dal controllo di qualità, dovrà incrociare le informazioni ricevute dal cliente tramite l’agente. Sulla scorta dell’analisi di quanto in suo possesso, l’addetto ha un quadro abbastanza preciso del problema tecnico e dovrà capire la sua entità economica. Dimensione economica della contestazione Prima di prendere qualsiasi decisione su come gestire con il cliente il problema dovrà, come detto, stabilire l’impatto economico dei passi che dovrà compiere con il cliente. Se l’ordine consegnato fa parte di un contratto continuativo, se è un ordine spot, se un inasprimento delle relazioni con il cliente potrebbe portare a dei risvolti negativi sulle vendite nell’area e, infine, valutare il rapporto che l’agente ha con il cliente e l’importanza che questo ha con l’azienda. A fronte del rischio di perdite commerciali o finanziarie importanti si dovrà studiare un approccio pragmatico, che metta nelle migliori condizioni le parti per dialogare. Nel caso in cui si è presenti a minori rischi, le valutazioni della strategia da seguire possono essere meno complicate. Importanza del cliente Se il cliente è importante per l’azienda che produce il prodotto, lo sa sia il responsabile commerciale ma anche il cliente stesso e, se non è uno sprovveduto, questa situazione è una delle maggiori difficoltà nelle trattative in caso l’azienda abbia una contestazione importante. Il problema non riguarda quindi solo la situazione oggettiva del momento, ma ci sono da considerare le implicazioni sul possibile fatturato, o di impegno della produzione, che potrebbero mutare se il cliente venisse perso. Viceversa, minore è l’importanza del cliente per l’azienda, minore sono i possibili rischi correlati alla contestazione. Anche qui prendiamo un esempio e inquadriamo il problema, attribuendo alla contestazione un valore economico e produttivo medio, una responsabilità media dell’azienda e un’importanza del cliente alta. Queste combinazioni si possono architettare diversamente, spostando i componenti e trovare soluzioni diverse. Gestione della contestazione Fatto salvi i tre punti riferiti al valore della contestazione, la responsabilità e all’importanza del cliente ci si deve muovere per minimizzare i costi e conservare una continuità cliente-azienda. In primo luogo bisogna valutare il grado di tensione che esprime il cliente che si sente danneggiato, questa è possibile rilevarla tramite le sensazioni che possono venire da una telefonata ricevuta o da un’email inviata o dalle indicazioni dell’agente. Se la tensione è palpabile è consigliabile astenersi nel formulare risposte scritte, che possono essere mal interpretate o che possono far salire ulteriormente la tensione. E’ auspicabile trovare un filo diretto telefonico, meglio in videoconferenza con il cliente in cui è possibile avere la possibilità di guardarsi in faccia e parlare. Se fosse possibile la visita dal cliente, questa potrebbe essere la migliore soluzione, in quanto è maggiormente empatica e sottolinea la volontà dell’azienda a considerare il cliente importante. Sono queste piccole sfumature di grande importanza che possono aiutare ad affrontare più serenamente il problema. L’incontro dovrà rimanere sempre, da parte del responsabile commerciale, su binari di educazione, rispetto e cortesia, anche in situazioni tese, senza pensare che possa diventare un duello personale. Questo non vuol dire una posizione di subalternità, anche in presenza di una responsabilità conclamata, ma un atteggiamento pragmatico che evita i rischi di una eccessiva emotività. L’esposizione delle cause della contestazione e della possibile risoluzione devono essere esposte dal responsabile dell’azienda in maniera competente, sia tecnicamente che economicamente, senza escludere una via di compromesso. Non sono consigliabili interventi in cui si cerchi di rovesciare tutta o in parte la colpa sul cliente per partire la negoziazione da un livello più sicuro, perché per fare questo si deve conoscere le capacità di gestione delle trattative da parte del cliente e la sua intelligenza. Se non si conosce a fondo l’interlocutore è meglio avere un approccio più sincero, meno da giocatori di poker, in quanto ci si può trovare di fronte ad un baro più bravo e, solo voi, conoscete il rischio che c’è sul piatto. La linea da sostenere deve avere una ragionevolezza che può valere per entrambi le parti, cercando di perseguire un equilibrio come asse portante delle relazioni tra le due aziende. Uscire dal problema spicciolo e far percepire al cliente il legame importante che nel tempo le aziende possono aver instaurato, può disinnescare prese di posizioni intransigenti, analizzando il valore della contestazione in relazione al fatturato consolidato. Lo scopo principale dell’incontro è disinnescare il risentimento e far crescere l’empatia tra i contendenti, così da partire da un piano non più in salita ma perlomeno orizzontale. Al cliente piace sentirsi apprezzato e una delle soluzioni è fargli capire che il problema sarà risolto, in quanto la relazione commerciale non potrà essere messa in discussione per una contestazione. Alla fine la proposta risolutiva dovrà tener presente il reale valore dell’errore commesso, il valore attribuito dal cliente al problema, considerando anche l’amplificazione dello stesso come gioco tra le parti, il valore della relazione azienda-cliente e la qualità dei rapporti personali che possono aiutare od interferire in problematiche future.
SCOPRI DI PIU'
 Moplen, Bramieri e il Carosello: Negli anni ’50 Nasce il Marketing Industriale
Moplen, Bramieri e il Carosello: Negli anni ’50 Nasce il Marketing IndustrialeMoplen, Bramieri e il Carosello: Negli anni ’50 Nasce il Marketing Industrialedi Marco ArezioAlla fine della seconda guerra mondiale il tessuto industriale italiano era praticamente distrutto, a causa degli intensi bombardamenti e della guerra civile che si era combattuta fino alla liberazione. La necessità impellente, negli anni successivi per il governo Italiano, era far ripartire la ricostruzione delle città che avevano subito ingenti danni e rimettere in sesto l’industria, in modo da poter assolvere ai bisogni dei cittadini. Vi era una povertà diffusa, una forte disoccupazione e una grande dipendenza da parte degli alleati, con in testa gli Stati Uniti, i quali varando il piano Marshall, convogliarono in Italia un’ingente quantità di denaro e di beni di prima necessità. Gli anni ’50 del secolo scorso videro faticosamente l’impegno di tutti per alleviare le sofferenze della popolazione che usciva da una guerra tremenda, si ricostruirono scuole, strade, fabbriche, si cercò di migliorare la resa dell’agricoltura, finalizzata ad una maggiore autosufficienza alimentare. Con il passare degli anni si riuscì a mettere in moto il mondo del lavoro con la conseguenza che, verso la fine del decennio, il tenore di vita delle famiglie iniziò piano piano ad aumentare. Le fabbriche del nord attiravano molti lavoratori che emigravano dal sud e, questo, costituì un volano per l’edilizia che creò nuovi alloggi, ampliando le città ed imprimendo un beneficio a tutto l’indotto. I tempi erano maturi per dotare le case degli italiani di nuovi prodotti necessari per una vita più modera, infatti, da pochi anni era nata la televisione, erano disponibili i frigoriferi, le lavatrici e molti altri prodotti per la casa. Un mercato immenso, che aveva bisogno di tutto, dove le aziende avevano la preoccupazione di produrre, far conoscere i nuovi prodotti e vendere. Qui nasceva una grande opportunità da parte delle aziende, che era rappresentata dagli spots televisivi della nuova televisione di Stato, che pubblicizzavano i prodotti all’interno del programma Carosello, sempre più visto dalla popolazione, in virtù dell’aumento delle vendite dei televisori. Quale mezzo più idoneo per convincere la gente a comprare i prodotti innovativi recitati da personaggi famosi e apprezzati dal pubblico. Un connubio poderoso fu il lancio dei prodotti in plastica fatti con il polipropilene, chiamato Moplen, che attraverso gli sketch di Gino Bramieri, famosissimo attore e comico, convinse la gente ad adottare i prodotti per la casa realizzati con il Moplen. Scolapasta, secchi, barattoli, ciotole, mastelli, giocattoli, attrezzature per lavare e molti altri prodotti erano non più realizzati in metallo o legno, pesanti e poco piacevoli alla vista, ma attraverso una materia prima che aveva molti colori, era duratura ed indistruttibile. Il genio italiano, Giulio Natta, ricevette nel 1963, per la creazione del polipropilene, come tutti sanno, il premio Nobel per la chimica e, l’Italia, era il paese ideale per la conferma di questo sviluppo. Forse, per la prima volta, le attività di marketing che hanno permesso una così ampia diffusione dei prodotti fatti in plastica, sono state da volano per altre aziende produttrici che utilizzarono i nuovi strumenti divulgativi, in maniera sempre più studiati ed efficaci. I messaggi pubblicitari, all’inizio, erano una via di mezzo tra un’attività teatrale e una di promozione, in modo soft, che coinvolgevano la gente che li guardava in modo divertente e spensierato. Bramieri fu un colosso in questo senso, in quanto realizzava duetti spiritosi, a volte vestito da donna, come se fosse una commedia comica, per poi mostrare i vantaggi dei prodotti in plastica all’interno della casa. Categoria: notizie - tecnica - plastica - moplen - marketing industriale - PP
SCOPRI DI PIU'
 Workaholism: La Dipendenza da Lavoro che Minaccia le Aziende
Workaholism: La Dipendenza da Lavoro che Minaccia le AziendeWorkaholism: La Dipendenza da Lavoro che Minaccia le Aziendedi Marco ArezioLa sindrome da ubriacatura da lavoro o dipendenza da lavoro è una malattia neuro-psichiatrica scoperta in America agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso. In questo articolo non tratteremo l’aspetto medico, cioè le mutazioni che questa malattia infligge sul soggetto malato, ma illustreremo le ricadute che può avere nell’ambito aziendale. Nel corso degli anni si è spesso confuso, forse per convenienza, la differenza tra uno stacanovista e un lavoratore affetto da dipendenza cronica da lavoro. Quale è la differenza vista dal punto delle attività aziendali? Lo stacanovista, che ha ruoli dirigenziali, lo possiamo vedere come un soggetto responsabile, affidabile, ambizioso e fidato che trascina il proprio team a raggiungere gli obbiettivi aziendali o i budget affidati, attraverso la costruzione di un clima competitivo e appagante i cui ogni partecipante al progetto si sente inserito in una catena motrice, con lo scopo comune di far girare il motore al giusto livello per raggiungere il traguardo comune. Collegialità degli obbiettivi, degli sforzi e delle gratificazioni sono la chiave per ottenere i migliori risultati lasciando, nel leader, ma anche i tutti i soggetti della squadra, la piacevolezza dell’impegno e la riconoscenza delle qualità dei singoli, ognuno nella giusta misura. La valorizzazione degli sforzi dei singoli e del team, a tutti i livelli, dona una sorta di protezione del branco e una carica autorigenerante per le sfide di tutti i giorni. Il leader che guida il gruppo, per stimolare le energie di tutti, deve essere inclusivo, rassicurante, sincero nell’illustrare rischi e obbiettivi, ma soprattutto deve sporcarsi le mani in prima linea, nella stessa trincea e condividere sul campo le strategie. In caso di raggiungimento degli obbiettivi il gruppo sarà compatto e più forte, soddisfatto, gratificato, sicuro del fatto che l’unione fa la forza e che, egoismi o prevaricazioni interne, siano deleteri per ognuno dei partecipanti. Se guardiamo invece il leder di un gruppo affetto da dipendenza da lavoro, ci troviamo di fronte ad un soggetto che vive per raccogliere adrenalina con la quale alimentare la propria giornata. Gli obbiettivi aziendali sono una scusa per applicare questa dipendenza alla propria vita, trascinando tutta la squadra in un ciclone di stress costante. Chi vive questa dipendenza mobilita una competizione sterile, volta ad accrescere il volume di lavoro in modo negativo, mettendo sotto pressione i collaboratori senza capire i limiti e le esigenze delle persone. Non è capace di fare squadra perché vive in modo egocentrico l’attività, quindi si rapporta con i colleghi come se fossero un tassello al proprio progetto finalizzato al risultato. Gli obbiettivi aziendali sono un propellente che alimenta la spirale di impegno, la benzina che accende un motore che deve girare al massimo e la componente umana non è considerata come parte della partita. Chi soffre di dipendenza da lavoro non riesce a staccare, perde il contatto con la vita reale e pretende che i collaboratori lavorino secondo il suo schema e i suoi interessi. Facilmente mette in cattiva luce chi non lo segue, crea zizania per incrementare la competitività reciproca, e non dialoga con la squadra. Non concepisce chi dissente o chi ha un atteggiamento verso il lavoro più equilibrato, dove ogni componente della propria vita deve avere un peso ponderato. Farsi dirigere da un soggetto che soffre di dipendenza da lavoro ha l’effetto negativo di lavorare in un ambiente in costante tensione, dove la paura di sbagliare riduce i risultati, dove il rischio di sfuriate dal leader del team sono all’ordine del giorno, con possibili conseguenze sulla posizione lavorativa. La paura di sbagliare o di essere traditi dai compagni di lavoro crea correnti interne, fazioni più o meno vicine al leader, il cui scopo non è più il raggiungimento del traguardo aziendale ma quello della sopravvivenza del rapporto di lavoro. I componenti del team tendono a ritirarsi in gusci protettivi, fanno quello che gli viene detto di fare, anche se lo reputano improduttivo od addirittura sbagliato. Non si espongono con idee o proposte per non esporsi a reazioni non calcolabili, sapendo quanto un soggetto affetto da questa malattia possa essere irascibile, scostante nell’umore e rischiando di mettersi in cattiva luce. Un ambiente come quello descritto focalizzato su un soggetto che crede di correre una gara da solo, umilia il lavoro di tutti, a volte anche le persone, trasformando la spinta propositiva di un team in passività lavorativa, lasciando al leader ogni decisione e ogni conseguenza. La spirale porta la figura apicale a doversi occupare di tutto, non avendo più una squadra su cui contare, con l’avvitamento del carico di lavoro e la riduzione della lucidità nelle decisioni e la trascuratezza della qualità generale dei risultati. Si crea uno scollamento che alimenta risentimento tra il leader e la squadra, un generale disinteresse all’azienda e al suo futuro, creando la costruzione di prove che possano difendere le singole posizioni in attesa della catastrofe imminente. Infatti, le giornate lavorative passano non finalizzate al miglioramento delle perfomances societarie, ma nell’attesa del giorno del fallimento della loro team, con la speranza che il loro comportamento minimale ed ossequioso possa salvargli il posto di lavoro. Se partiamo da un paradigma molte volte usato, ma reale, che dice che i successi delle aziende sono fatti di persone guidate da leader capaci, dobbiamo quindi monitorare comportamenti eccessivi sia di lassismo che di iper lavoro.
SCOPRI DI PIU'
 La Storia delle Soffiatrici per le Materie Plastiche: dal Vetro alla Plastica
La Storia delle Soffiatrici per le Materie Plastiche: dal Vetro alla PlasticaLa Storia delle Soffiatrici per le Materie Plastiche: dal Vetro alla Plasticadi Marco ArezioLa storia delle soffiatrici per le materie plastiche affonda le sue radici all’inizio del secolo scorso, quando si iniziò a pensare ad imballi per alimenti liquidi, come il latte, prodotti in materiali più leggeri rispetto al vetro.Non erano però ancora del tutto maturi i tempi in quanto il materiale plastico per eccellenza, l’HDPE, non aveva fatto ancora la sua presenza nel mondo della produzione dei flaconi. La possibilità di ottenere prodotti finiti in forma completamente cava, mediante soffiaggio di un materiale termoplastico, era nota fin dal 1920 ed applicata per alcuni oggetti di cellulosa e di vetro. Fu una vera rivoluzione, se pensiamo che il packaging era da sempre monopolizzato dalle bottiglie di vetro che risalgono, con certezza, al periodo dei Faraoni in Egitto, avendo trovato all’interno delle tombe, vasetti e contenitori funerari in vetro artigianale. Sebbene, la nascita del vetro soffiato, antesignano delle moderne bottiglie di vetro, la possiamo far risalire al I° secolo a.C., quando si sperimentò per la prima volta la soffiatura del vetro attraverso un tubo metallico cavo. Con la soffiatura a canna la produzione divenne più veloce ed economica dando la possibilità di produrre bottiglie, fiaschette, e recipienti adatti anche al popolo e non solo oggetti per i ricchi. Così, nel 1938, due inventori Americani, Enoch Ferngren e William Kopitke, pensarono a un modo per utilizzare i principi della soffiatura del vetro nell'industria della plastica. Crearono così la prima soffiatrice per plastica e la vendettero alla Hartford Empire Company. Ma bisogna arrivare agli anni ‘40 per vedere i primi successi di questa tecnologia, dovuti principalmente all’introduzione del polietilene. Questo materiale, e poi anche il PVC, consentirono la produzione su vasta scala di bottigliette soffiate. Il maggiore sviluppo di questa tecnologia risale però ai primi anni ‘60, quando vennero meno alcune limitazioni brevettuali. Il processo di soffiaggio è sostanzialmente analogo a quello della soffiatura del vetro, tant’è che molti dei primi operatori delle soffiatrici automatiche e robotizzate prevenivano da quel settore. La prima tecnologia di soffiaggio di corpi cavi fu quella di estrusione-soffiaggio, applicata prima per piccoli flaconi e in seguito per grossi contenitori da 5 litri; seguì la tecnologia dell’iniezione-soffiaggio, utilizzata soprattutto per flaconi e bottiglie per uso farmaceutico e cosmetico. I Pionieri Italiani La storia del soffiaggio di corpi cavi incominciò in Italia con Giuseppe Moi, un sardo che trasferitosi a Milano nel 1937 riuscì ad inserirsi con entusiasmo nell’attività industriale di questa città; dopo cinquant’anni di attività, nel 1987, Moi aveva costituito in Italia ed all’estero una trentina di società. La prima attività indipendente di questo straordinario personaggio fu lo stampaggio ad iniezione nel 1945-49 di articoli religiosi e giocattoli di materiale plastico. Nel 1950 fu fondata la G.Moi, che un anno più tardi fabbricò la prima soffiatrice italiana da mezzo litro, dotata di estrusori bivite, destinata alla produzione di bottigliette per detersivi. A questa soffiatrice seguirono macchine da 2, 10, 50 e 500 litri (1962); a partire dai modelli da 10 litri, gli impianti erano attrezzati con testa ad accumulo. L’attività della Moi cessò nel 1980 quando i brevetti e la tecnologia furono trasferiti alla Triulzi, che continuò la costruzione di queste soffiatrici destinate soprattutto alla produzione di grandi manufatti per l’industria automobilistica. Giuseppe Moi ha al suo attivo anche la costruzione delle prime macchine per l’estrusione di lastre e tubi di PE espanso, fornite anche negli Stati Uniti. La storia continua con due società un tempo separate ed oggi divisioni del gruppo americano Uniloy: la Moretti e la Co-Mec. La prima fu fondata nel 1957 dai fratelli Domenico e Giorgio Moretti ad Abbiategrasso, con la ragione sociale: "Officina meccanica per la costruzione di macchine e stampi per il soffiaggio di corpi cavi in materiale plastico". Oltre a queste macchine la società costruì estrusori, teste per l’estrusione, filiere e traini per tapparelle e piccole calandre. Una delle prime macchine soffiatrici, costruita nel 1959, era di tipo pneumatico ad estrusione continua per la produzione di contenitori da due litri per detergenti. Nel 1961 fu costruita la prima macchina per l’estrusione soffiaggio di contenitori fino a 30 litri e la società si impose come una delle principali costruttrici di macchine per il soffiaggio di pezzi tecnici. La Co-Mec, fondata nel 1960 da Herberto Hauda, operava inizialmente a Firenze come trasformatore di materiali plastici. In seguito la sede fu trasferita a Calenzano (FI) dove incominciò la costruzione anche di macchine. Fino al 1965 la Co-Mec costruiva soffiatrici pneumatiche con capacità massima di 5 litri; nel 1966 fu messa sul mercato la prima macchina idraulica, a testa doppia fino ad un litro ed a testa semplice per contenitori fino a 5 litri. Verso la metà degli anni ‘60 furono fabbricate teste speciali per bicomponenti (PVC e PE), con colorazione a strisce. E’ da citare l’azione promotrice in questo settore di Piero Giacobbe, noto anche perché nel 1954 fondò il Giornale delle materie plastiche ceduto poi alla SIR. Giacobbe, oggi titolare con il figlio Ferruccio del gruppo Magic, fondò nel 1960 la ASCO (Associazione costruttori macchine materie plastiche) che mise sul mercato impianti di soffiaggio corpi cavi. Il primo impianto di soffiaggio, chiamato Olimpia, risale al 1960, mentre un anno più tardi fu costruito il modello Mini Magic, che anticipa nel nome la futura società Magic MP. All’inizio degli anni ‘70 si affermò anche in Italia una forte industria costruttrice di macchine per il soffiaggio di corpi cavi, anche se la produzione era allora limitata all’estrusione-soffiaggio e non all’iniezione-soffiaggio. L’offerta copriva dalle piccole unità per contenitori farmaceutici sino agli impianti completi per fusti e contenitori di mille litri ed oltre. Risale a quegli anni lo sblocco dell’impiego del PVC atossico, stabilizzato ai raggi UV ed antiurto, per il soffiaggio di bottiglie destinate alle acque minerali non gasate. Quattro stabilimenti di imbottigliamento incominciarono ad adottare il PVC per questo impiego. Nel 1970 erano presenti in Italia undici costruttori, contro i quattro del 1960. La CoMec mise in commercio nel 1970 una soffiatrice con ugello di soffiaggio dall’alto e con calibrazione del collo. Nei primi anni ‘70 sviluppò l’estrusione-soffiaggio di corpi cavi di nylon ad elevata viscosità e nel 1973 propose la Serie CS anche per la coestrusione fino a tre strati. La Fratelli Moretti costruiva quattro modelli di soffiatrice Serie M, ad un gruppo, per contenitori di PVC fino a sei litri di capacità e quattro modelli MB a due gruppi con smaterozzamento ed espulsione automatici; inoltre proponeva la serie Compact, con cinque modelli per contenitori da 20 a 250 litri ed estrusori fino a 120 mm di diametro. La Omea forniva due modelli di soffiatrice automatica con estrusore verticale e quattro tipi con estrusore orizzontale (fino a cinquanta litri): la testa era del tipo ad accumulo con regolazione dello spessore del parison. La Beloit Italia di Pinerolo (TO) costruiva due diversi modelli a stazioni rotanti (fino a sei). Troviamo poi tre società: la Newpac di Zingonia (BG), la Costaplastik di Macherio (MI) e la Mossi e Ghisolfi di Tortona, che dopo un’attività di trasformazione, iniziarono la costruzione di alcuni tipi di soffiatrici. La Mossi & Ghisolfi si era specializzata nella costruzione di impianti completi per la produzione di bottiglie per latte; commercializzava inoltre le macchine della francese Sidel, destinate alla realizzazione di bottiglie di PVC per acqua minerale, vino ed olio. La Locati e Pavesi di Milano si era fatta un nome con il modello LP 200 per contenitori fino a 5 litri, caratterizzato da un sistema di chiusura delle piastre attuato mediante robuste ginocchiere. La Magic, fondata come è stato detto da Piero Giacobbe nel 1965, acquisì ben presto un posto importante nel panorama dei costruttori italiani di macchine per contenitori fino a 200 litri; in particolare si segnalano i modelli Miniblow per la lavorazione del PVC rigido per uso alimentare, con smaterozzamento automatico in produzione e calibratura dei colli e Maxiblow, quest’ultimo per corpi cavi sino a 50 litri, con testa ad accumulo e regolazione dello spessore e del peso del parison.Categoria: notizie - tecnica - plastica - soffiatrici - storia Foto Kautex Fonti: IQS-Donadini-Kautex
SCOPRI DI PIU'